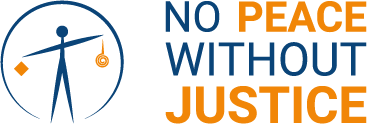Leggi l’articolo pubblicato in Affari Internazionali
Il 13 luglio scorso, mentre ci si apprestava a celebrare il quattordicesimo anniversario dell’adozione dello Statuto della Corte penale internazionale, avvenuta a Roma il 17 luglio 1998, il ministro della giustizia del Mali scriveva al Procuratore della Corte all’Aja per chiedere formalmente il deferimento del suo paese alla giurisdizione della Corte stessa “nella misura in cui la giurisdizione maliana è nell’impossibilità di perseguire o giudicare gli autori”.
Il ministro elencava poi una serie di gravi crimini commessi in Mali a partire dal gennaio 2012: esecuzioni sommarie, stupri, massacri di civili, arruolamento di bambini, torture, saccheggi, rapimenti, distruzione di simboli religiosi. Crimini, precisava, che ricadevano sotto gli articoli 7 e 8 dello Statuto della Corte.
Innegabilmente, il mondo è molto cambiato da quando lo Statuto è entrato in vigore il primo luglio 2002. Dieci anni fa non esisteva alcun organismo permanente che avesse giurisdizione su crimini attinenti al diritto internazionale. Il fatto che la Corte sia riuscita a rimanere in vita tutti questi anni nonostante lo scetticismo sparso a piene mani e le forti opposizioni, è di per sé già foriero di risultati promettenti.
Deterrenza
Il primo risultato, come dimostra il recente caso maliano, è che le vittime hanno la possibilità di vedere riconosciute le ingiustizie subite, il che non era pensabile dieci anni fa.
Anche per questo, misurare il successo della Corte sul numero di indagini, procedimenti giudiziari o condanne è alquanto singolare. Anzi, se questo dovesse essere il metro di giudizio allora si potrebbe dire che il massimo successo la Corte lo avrà raggiunto quando non avrà più alcun caso da trattare, visto che opera in base al principio della complementarietà che lascia agli Stati la responsabilità primaria in materia di indagine e, nel caso, di condanna.
Non si tratta quindi di fare un balletto sulle cifre – che rischia di banalizzare il contesto – ma piuttosto di guardare alla rilevanza e all’impatto che la Corte ha, e può avere, come deterrente.
Ebbene, nonostante la realpolitik imperante, gli effetti deterrenti della Corte hanno iniziato a dispiegarsi. Il loro “sfruttamento” da parte di politici e attivisti a livello nazionale ha messo un freno alla violenza, anche senza il coinvolgimento diretto della Corte. L’effetto deterrente è accresciuto dalla strategia dell’accusa di concentrarsi su coloro che hanno le responsabilità più gravi per i crimini commessi dall’insieme, il che comporta attribuire le responsabilità a chi effettivamente ne è titolare, evitando così di criminalizzare interi gruppi, inclusi quelli etnici.
Lotta all’impunità
Ma l’impatto principale della Corte a livello globale è che oggi non è più possibile ignorare le responsabilità, guardando dall’altra parte. Qualsiasi situazione che veda massicce violazioni incrocia, ad un certo punto, la questione dell’impunità, anche dove esistono dinamiche politiche che proteggono i perpetratori, come nel caso della Siria.
Oggi per queste situazioni esiste un canale, che presuppone però una volontà politica: quello del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Dieci anni fa l’unica opzione percorribile era la creazione di tribunali ad hoc, mentre adesso è disponibile una giurisdizione alla quale il Cds può deferire dei casi. E se alcuni membri permanenti oppongono il veto, ora se ne conoscono nome e cognome.
Un altro effetto collaterale della Corte è la rivisitazione delle vittime come persone sopravvissute titolari di diritti, più che come oggetti di pietà, come pure il fatto che la necessità di lottare contro l’impunità abbia permeato la questione nei suoi termini generali a livello internazionale. La Corte ha anche aiutato a rafforzare l’azione punitiva rispetto ai crimini contro donne, giovani e bambini. La condanna a 14 anni di detenzione comminata al congolese Thomas Lubanga, che arruolava bambini soldato, è in questo senso un precedente significativo.
Armi spuntate
Tuttavia, la Corte è spesso disarmata di fronte ai mandati di arresto che non vengono eseguiti a causa di certi Stati che si mettono di traverso, violando gli obblighi previsti dallo Statuto. Siamo in assenza di un meccanismo sanzionatorio. Lo scorso anno, ad esempio, numerosi Stati contraenti hanno impunemente ricevuto Omar Al Bashir, il presidente del Sudan contro il quale la Corte ha spiccato un mandato di cattura. Per questo, la recente e coraggiosa decisione del piccolo Malawi di non ospitare la sessione di luglio 2012 dell’Unione africana, che prevedeva la presenza di Al Bashir, è stata una ventata di aria fresca.
D’altra parte, il rifiuto di cooperare con la Corte da parte dell’Unione africana rappresenta un’ovvia contraddizione con l’impegno, scritto nel suo atto costitutivo, di lottare contro l’impunità e per l’affermazione della giustizia penale internazionale. Ai detrattori africani della Corte, che vedono in essa uno strumento parziale, va ricordato: gli Stati africani non ne sono il bersaglio privilegiato ma ne sono i principali utilizzatori. In effetti, non solo hanno svolto un ruolo prezioso nel suo processo di creazione, ma si sono anche rivelati tra i paesi più attivi nel deferimento volontario alla Corte.
Neppure l’Italia può sottrarsi da un esame di coscienza. Dopo essere stato uno dei paesi che più si è speso a livello diplomatico per rendere possibile la Corte e tra i primi a ratificarne lo Statuto, ad oggi non ha ancora adeguato il suo ordinamento interno. L’esame del disegno di legge di adeguamento è iniziato alla Camera dei deputati nel 2009 e, da quel momento, è rimasto ostaggio di un’interminabile ping-pong tra i due rami del Parlamento.
Come denunciato durante la tavola rotonda organizzata al Senato il 17 luglio dall’associazione radicale “Non c’è Pace senza Giustizia”, questo clamoroso ritardo fa sì che le autorità italiane non possano cooperare con la Corte nelle sue attività inquirenti e giudicanti e, di fatto, pone l’Italia in posizione di flagrante inadempienza, facendone un potenziale rifugio per gli autori dei più efferati crimini contro l’umanità. Se per ipotesi il già citato Omar al-Bashir si trovasse sul nostro territorio, il giudice italiano non avrebbe alcuno strumento normativo per eseguire il mandato di arresto.
Nessuna pace senza giustizia
Certo, la Corte non è sempre la risposta più adeguata ma la sua esistenza ha generato l’aspettativa per cui silenzio e inerzia a fronte di atrocità non sono più un’opzione possibile. Per mantenere e rafforzare il suo ruolo, la Corte deve tuttavia mostrare di avere i denti per mordere: per farlo deve essere stabilmente finanziata e politicamente sostenuta; e deve migliorare il proprio metodo di lavoro, soprattutto sul terreno con i rappresentanti delle organizzazione per i diritti umani e con le comunità locali.
Per quanto imperfetta possa essere, la Corte contribuisce al raggiungimento di un ideale per il quale migliaia di militanti ad ogni latitudine hanno lottato e continuano a lottare con tenacia. Ed è anche frutto di una convinzione profonda: la pace – quella durevole fondata sulla supremazia del diritto – e la giustizia sono due facce della stessa medaglia. Ristabilire l’una non può avvenire senza la piena affermazione dell’altra. E viceversa.
*Niccolò Figà-Talamanca è Segretario generale di “Non c’è Pace senza Giustizia”.